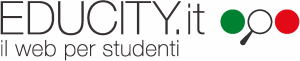
EDUCITY sceglie per te solo siti approvati da un team di professori delle scuole italiane. La ricerca è subito mirata. Il motore di Google Co-Op trova e ordina i risultati. Il meglio del Web risparmiando tempo e fatica.
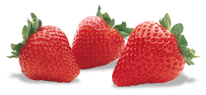 I TESTI DEL BLOG I TESTI DEL BLOG |
|---|
Cos' è il riscaldamento globale ?
Una ricerca scolastica da fare.
Questa volta partendo da un film.
Il documentario del regista Davis Guggenheim: Una scomoda verità An Inconvenient Truth offre uno sguardo appassionato sulla lezione multimediale dell'ex Vice Presidente USA Al Gore e ci mette con chiarezza di fronte alle problematiche legate alla necessità di fermare avanzata del riscaldamento globale (Global Warmings) smascherando i miti e i fraintendimenti che la circondano.
" Il diossido di carbonio ed altri gas riscaldano la superficie del pianeta naturalmente trattenendo il calore solare nell'atmosfera. Questa e' una buona cosa perchè rende il nostro pianeta abitabile. Purtroppo però, bruciando combustibili fossili come carbone, gas e petrolio e distruggendo le foreste abbiamo incrementato drammaticamente la quantità di diossido di carbonio nell'atmosfera terrestre e le temperature stanno salendo.
La maggioranza degli scienziati concorda sul reale riscaldamento del globo, è già successo ed è il risultato delle nostre attività e non un fatto naturale. La prova e' schiacciante e innegabile. Stiamo gia' vedendo i cambiamenti. I ghiacciai si stanno sciogliendo, le piante e gli animali sono forzati nei propri habitat e il numero di uragani e siccità sta aumentando."
Questo è il tema, affrontato con chiarezza e in modo coinvolgente anche per i nostri studenti, benché il documentario sia in parte localizzato per il pubblico statunitense.
Nel caso delle scuole pubbliche spetta al dirigente definire le modalità d'uso di tali strumenti, tenendo conto dei diritti dei docenti e della disciplina in tema di relazioni sindacali.
Gli ambiti principali investiti dalla prescrizione del Garante sono due: l'uso delle e-mail e la navigazione in Internet.
L'uso delle e-mail dovrà essere regolamentato dai dirigenti secondo tre modalità principali nel rispetto delle disposizioni a tutela della privacy del docente e dei terzi:
- la lettura e scrittura della posta elettronica personale del docente per i suoi indirizzi e-mail privati;
- la lettura e scrittura della posta elettronica per il suoi indirizzi e-mail relativi alla posta ufficiale del Ministero dell'Istruzione o del sito della scuola;
- la lettura e scrittura della posta elettronica con la quale il docente comunica con alunni e famiglie.
La regolamentazione della navigazione in Internet da parte dei docenti presenta più difficoltà per tutta una serie di particolarità che debbono essere considerate in aggiunta a quanto stabilito dal Garante per la generalità dei datori di lavoro pubblici.
Il dirigente scolastico, se si dovesse comportare come quello di un normale ente pubblico, dovrebbe innanzitutto predisporre idonee misure di sicurezza per assicurare la disponibilità e l'integrità di sistemi informativi e di dati, anche per prevenire utilizzi indebiti che possono essere fonte di responsabilità (artt. 15, 31 ss., 167 e 169 del Codice) e non potrebbe in ogni caso far eseguire la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dai dipendenti in servizio. Dovrebbe poi procedere all'individuazione di categorie di siti considerati correlati o non col lavoro dei dipendenti o far configurare sistemi o filtri che prevengano l'accesso a determinati siti e il tutto trattando i dati in forma anonima o tale da precludere l'immediata identificazione dei soggetti che accedono alla rete Internet e stendere infine il relativo disciplinare interno.
Ma il dirigente scolastico ha a che fare con una scuola e quindi il suo compito è solo quello di assicurare la gestione unitaria dell'Istituzione scolastica e la direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse, e non ha a che fare con la sindacabilità dei contenuti e lo specifico del contenuto del lavoro docente.
Per questo, risulta immediata la necessità di adattare la prescrizione del Garante alla particolarità di un agenzia educativa pubblica in quanto la scuola è una formazione sociale nella quale va assicurata la tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati garantendo che, in una cornice di reciproci diritti e doveri, sia assicurata l'esplicazione della personalità dei docenti e degli studenti con una ragionevole protezione della sfera di riservatezza nelle relazioni personali e professionali (artt. 2 e 41, secondo comma, Cost.; art. 2087 cod. civ.; cfr. altresì l'art. 2, comma 5, Codice dell'amministrazione digitale d.lg. 7 marzo 2005, n. 82), e di regola la libertà di insegnamento (art. 33, Cost.) preclude radicalmente la possibilità per il dirigente scolastico di individuare o escludere siti Web alla navigazione da parte dei professori.
Così come, entro gli obiettivi definiti dalle leggi e dal POF, è libera per i docenti la scelta dei libri di testo o dei materiali didattici da impiegare in classe così è in generale libera la scelta dei siti Web da far consultare ed in generale utilizzare dagli studenti.
La funzione docente, fondata sulla libertà di insegnamento, intesa come libertà della funzione a tutela di un inderogabile interesse pubblico non tollera invadenze nei confronti della ricerca e nell'analisi dei materiali mediatici sia che essi siano reperiti in una libreria, in una biblioteca o con ricerche in Internet.
La tematica è resa ancora più complessa dalla considerazione della navigazione e delle ricerche in Internet da parte degli studenti. Visitare un sito a scuola da parte dei soggetti minorenni equivale alla consultazione di materiali didattici o fotocopie messe a disposizione dall'insegnante.
Formalmente non è lo studente che visita il sito ma è il professore che guida il mouse dello studente sulle pagine Web e ne è responsabile.
Per questa ragione quando il dirigente volesse registrare in modo generalizzato la navigazione Internet degli studenti in realtà effettuerebbe una illecita registrazione delle attività dei docenti.
Le soluzioni alla regolamentazione della navigazione in Internet da parte dei docenti e di conseguenza degli alunni, tenuto conto della particolarità del sistema scolastico pubblico, vanno discusse all'interno del Collegio Docenti e rapidamente implementate secondo le indicazioni del Garante e le specifiche caratteristiche della funzione docente.
Un' ultima considerazione circa la funzione che svolge un motore di ricerca chiuso come EDUCITY.IT come parte delle possibili soluzioni. Nell'ambito della libertà di scelta dei docenti che partecipano alla selezione dei contenuti, EDUCITY.IT consente a professori e studenti di fare ricerche in Internet in uno spazio sicuro e referenziato. Si può usarlo o meno senza limiti di accesso o configurazioni particolari in ogni scuola italiana, è già filtrato, è in costante crescita e gli aggiornamenti sono subito disponibili per tutti.
La pubblicita' a scuola e Internet
L'autonomia di cui godono oggi le scuole pubbliche consente di ipotizzare contratti tra le scuole e gli inserzionisti per la vendita di spazi pubblicitari all'interno degli istituti.
Nel 2006 la pubblicità all'interno degli spazi scolastici è stata oggetto di proposte e relative critiche a Genova e nella Regione Veneto.
I dirigenti scolastici che si sono mossi in questa direzione rilevano l'utilità per le casse scolastiche di entrate periodiche a fronte di pubblicità. Le reazioni di genitori ed alunni non si sono comunque fatte attendere e per lo più è prevalso un senso di indignazione. Comunque il dibattito è aperto e questo è quello che conta.
Ben diverso è il problema della pubblicità a scuola quando non è gestita o peggio viene fatta sotto gli occhi di dirigenti e professori senza che la scuola abbia stipulato alcun contratto in merito.
Due situazioni in particolare.
La prima riguarda gli innumerevoli distributori di bevande e merendine collocati nelle scuole della penisola su cui compaiono a tutta parete o in modo più mascherato i loghi pubblicitari delle bibite, degli snack o altro.
Quale è il valore che l'inserzionista pubblicitario riceve gratuitamente dalla scuola dato che i suddetti distributori trasformati di fatto in cartelloni pubblicitari sono solitamente collocati proprio nei luoghi ove stazionano negli intervalli centinaia di studenti? Target mirato, consumatori giovani che spenderanno ancora per moltissimi anni, ambiente senza altra pubblicità concorrente... Quale responsabilità per i dirigenti che non fanno rimuovere o in alternativa non contrattualizzano tali pubblicità ?
La seconda situazione riguarda la navigazione in Internet degli studenti.
Sappiamo tutti come i siti Web stiano diventando ogni giorno sempre più gli strumenti migliori per le campagne pubblicitarie e, nel mondo futuro dei nostri allievi, pare saranno "il" luogo per eccellenza della pubblicità. Quando uno studente visita un sito, e il discorso intendiamoci vale anche per molti siti sicuri e seri selezionati per le pagine di Educity, riceve decine e decine di messaggi pubblicitari. Quando lo fa a scuola è la scuola o meglio il professore che formalmente gli presenta i contenuti di pagina e quindi anche la pubblicità, non la rete Internet badate bene.
Visitare un sito a scuola equivale alla consultazione di materiali didattici o fotocopie messe a disposizione dall'insegnante. Rientra, sia detto per inciso, nella sua autonomia didattica non sindacabile dai Dirigenti e per converso nella sua responsabilità.
Se la pubblicita' compare su riviste, fotocopie o giornali usati in classe dall'insegnante, la sua presenza è marginale direi quasi casuale. Sul Web è molto diverso: l'inserzionista pubblicitario in Internet spesso sa che la pagina Web è chiesta da un indirizzo corrispondente ad una scuola ed invia pubblicità specifica per i nostri alunni, fa preparare pagine per studenti con pubblicità mirata e inserita nel contesto di pagina in modo tale da non poter essere ignorata, è lui che spesso paga i creatori dei contenuti per arrivare ai giovani consumatori di oggi e domani.
La pubblicità dedicata agli studenti, sui siti che si consultano all'interno delle scuole, è un problema di cui cominciare a tener conto.
Nella scuola Pubblica non possiamo ignorare, sia nel caso dei distributori automatici come per la navigazione internet, i conflitti di interessi pubblici e privati sulla formazione dei futuri consumatori.
“I bambini, e soprattutto gli adolescenti, sono spesso un obiettivo difficile per gli inserzionisti”, constata Gary Ruskin, direttore di Commercial Alert. “Per questo, i venditori di prodotti vanno là dove si trovano i ragazzi, là dove sono costretti a stare: a scuola”
Ricerche in Internet
___________________________________________________________________________
Grazie a Google, EDUCITY cerca solo in una biblioteca di siti (link) selezionati dagli insegnanti, esattamente come accade per i libri di testo.
Incompetenza, eccessi pubblicitari, spazzatura, sono eliminati in partenza. Basta digitare le parole chiave e Google cerca le corrispondenze all'interno della selezione.
E'uno straordinario passo avanti, in un settore nel quale fino a ieri eravamo impotenti o quasi.
Naturalmente i siti minitorati da EDUCITY sono in continuo aggiornamento. Eventuali mancanze saranno perciò risolte nel tempo anche grazie alla tua collaborazione. Sulla prima pagina c'è un link per segnalare siti utili
EDUCITY è lo strumento di lavoro ideale per studenti e insegnanti. Gli studenti hanno finalmente un vasto portafoglio di siti sicuri da sfruttare per le loro ricerche, mentre gli insegnanti possono indirizzarli con facilità all'interno di questo universo ed hanno finalmente la possibilità di consigliare un sito di ricerche in Internet per i compiti a casa. Tutto il resto rimane fuori.
Che cosa ne pensi? In questo blog puoi commentare, suggerire, criticare. Grazie per l'attenzione.
Information Overload
___________________________________________________________________________
Più passa il tempo, più cresce la mole di informazione disponibile in Internet tanto che ci si prefigura una crisi generalizzata dal nome molto significativo di information overload. Questa sindrome può avere effetti non solo di tipo cognitivo ma anche prettamente fisico: stati d’ansia e stress. Neanche i bambini e i ragazzi, che sono comunemente considerati psicologicamente molto più ricettivi degli adulti alle nuove applicazioni della tecnologia, non ne sono immuni, anzi, più sono piccoli più l’impatto con il flusso informativo delle nuove tecnologie genera disagio e frustrazione. Da una recente indagine italiana risulta che l’attività più frequente che i docenti svolgono assieme agli studenti quando utilizzano Internet a scuola sia proprio la ricerca di informazioni, mentre da un monitoraggio effettuato nel 2000 sui docenti del Progetto 1B viene riportato che la ricerca di materiali in Internet è fra le preferite (45% del tempo).
Ma nonostante un generale riconoscimento dell’importanza di questi temi, (molti piani di offerta formativa, POF, di vari istituti scolastici cominciano ad includere azioni educative in questo senso) sorprendentemente vi sono stati sinora pochissime ricerche e studi specifici a livello nazionale ed internazionale, sulle abilità di ricerca dell’informazione in Internet, soprattutto per quanto riguarda gli studenti più giovani. Da questi studi preliminari sembra necessario già nella prime classi della scuola, aiutare a costruire quelle abilità di ricerca in rete che permetteranno agli studenti di selezionare le informazioni e di strutturarle in aggregati significativi di conoscenza, ampliando in questo senso una visione costruttivistica, che vede gli studenti proprio come soggetti attivi nella creazione e la condivisione di nuova conoscenza. Gli anglosassoni hanno da tempo coniato un termine per definire quell’insieme di abilità richieste dall’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione: l’information literacy. Sono in sostanza quelle capacità che permettono di riconoscere quando è necessaria una certa informazione e che mettono in grado la persona di sapere dove e come cercarla, di valutarla e di utilizzarla efficacemente...
Il vero, il falso e il finto
___________________________________________________________________________
Quanta verità in quelle bugie Il vero, il falso e il finto nelle osservazioni di Carlo Ginzburg, in libreria con il nuovo saggio "Il filo e le tracce" di Carlo Baja Guarienti
"Non è sufficiente dimostrare la falsità di un documento per fermare le sue conseguenze nella realtà" Vero, falso, finto. Su questa triade, che è anche il sottotitolo del libro, riflette Carlo Ginzburg nel suo più recente lavoro, "Il filo e le tracce", edito da Feltrinelli. Tre concetti che possono sembrare a prima vista evidenti nel loro significato, immuni dal bisogno di una riflessione in quanto assiomi della ricerca storica; ma spesso è proprio il linguaggio, codice all'apparenza semplice e univoco, a nascondere le insidie maggiori.
Nei saggi raccolti in questo volume l'autore continua un discorso da lui già affrontato in precedenza, una tematica talvolta perseguita come obiettivo esplicito e talvolta leggibile nella filigrana delle pagine dedicate ad altri temi: l'esame del rapporto fra il significato evidente di un documento e i suoi molteplici significati nascosti, ovvero la possibilità di ricavare da un testo ciò che esso non vorrebbe rivelarci. Già Marc Bloch aveva teorizzato questa "grande rivincita dell'intelligenza sul mero dato di fatto ": la capacità dello storico di ingannare per così dire un documento traendone tutta una gamma di informazioni non previste dall'autore. Autore che finisce così per dire di sé, del suo tempo, del suo mondo molto più di quanto non dica dell'oggetto da lui stesso preso ad argomento. Incontriamo Carlo Ginzburg nella sua casa di Bologna Nei saggi raccolti in questo libro, accanto a fatti e personaggi appartenenti al Rinascimento o a epoche precedenti, traspare spesso l'ombra di eventi del Novecento: lo studio di un lontano passato gli chiediamo può davvero aiutarci ad interpretare il nostro tempo? "è impossibile non tenere conto del Novecento nel momento in cui ci rivolgiamo al passato per interrogarlo: riprendendo Croce, si può dire che ogni storia è storia contemporanea. Però non dobbiamo aspettarci che il passato parli il nostro stesso linguaggio: in ciò che riusciamo ad ottenere interrogando la storia difficilmente troveremo risposte consone fino in fondo alle nostre domande sul presente.
Alcuni storici sono più ottimisti sulle opportunità che lo studio di questa disciplina ci offre, ma io credo che ci sia un limite: certamente la conoscenza del passato ci fornisce qualcosa di importante come un punto di vista diverso, una prospettiva, ma è rischioso applicare le risposte di questo passato al futuro" Questo inizio di secolo è un'era di guerre e di sovrapproduzione di documenti: come potranno gli storici del futuro raccontare il nostro presente? "Certamente una sovrabbondanza di documentazione espone lo storico al rischio della superficialità nell'indagine: là dove gli storici dell'antichità hanno dovuto sviluppare complessi strumenti ermeneutici per ricavare il massimo da un corpus limitato di fonti, gli storici della contemporaneità potrebbero scontrarsi oltre che con la mancanza di distanza psicologica dall'oggetto dei loro studi con il problema dell'eccesso di testimonianze. Ma le domande dello storico sono sempre più delle risposte, per cui anche una documentazione abbondante non sarà mai in grado di rispondere a tutti i quesiti possibili. Va aggiunto che oggi gli storici dispongono di strumenti (basti pensare a Google) adatti a raccogliere e catalogare le fonti; ma quando si tratta di interrogarle internet non serve. Del resto non è un problema nuovo: anche per gli eventi del passato, rispetto ai quali è impossibile padroneggiare ogni particolare e ogni aspetto, è necessario formulare domande che circoscrivano il campo dell'indagine e mettano a fuoco le tracce da seguire".
E per quanto riguarda la possibilità che in questa massa di documenti qualcuno sia volutamente ingannevole? "Una tecnica per ovviare a questo inconveniente è quella usata da Arsenio Frugoni nella ricostruzione della vicenda di Arnaldo da Brescia. In questo caso le diverse fonti danno diverse immagini del personaggio, ma Frugoni ha scartato l'idea di integrare meccanicamente fra loro le voci: è più importante collegare i ritratti di Arnaldo tenendo in primo piano il filtro adottato dalle fonti nel restituire un punto di vista. La pars destruens di questo metodo si oppone alla tradizione positivista di utilizzo delle fonti in un'ottica neutra". Stendhal scrisse: "Credo che la verità, nelle piccole cose come nelle grandi, sia quasi irraggiungibile".
Qual è il compito dello storico? Si può sperare di raggiungere qualche verità, oppure è inevitabile cedere allo scetticismo relativista? "Stendhal rivolge questa domanda a se stesso e in qualche modo si risponde con "Il rosso e il nero", risposta complessa e a suo modo ironica: una cronaca romanzata, una verità nella finzione.
Io ho cercato di esaminare la trasparenza illusoria di questi tre termini vero, falso, finto per dimostrare che è possibile rintracciare una parte di verità anche nel falso; questo non significa affatto affermare una continuità senza interruzioni fra vero e falso, ma il possibile valore del falso e del finto nella ricerca del vero.
La verità è irraggiungibile? Meglio dire che la verità non è mai definitiva, è sempre revocabile: le affermazioni dello storico sono vere fino a prova contraria. Inoltre bisogna considerare la forza che possono avere eventi non realmente accaduti: il falso può avere una potenza enorme e a volte - come nel caso dei "Protocolli dei Savi di Sion" non è sufficiente dimostrare la falsità di un documento per fermare le sue conseguenze nella realtà ".
© 2006 - 2018 EDUCITY il web per studenti - Firenze Italia - Powered by Google Co-Op ® Google Inc. Mountain View Ca. U.S.A.
Fight Spam! Click Here!